Cesare Pavese, L’Intruso – Recensione di Simone Consorti
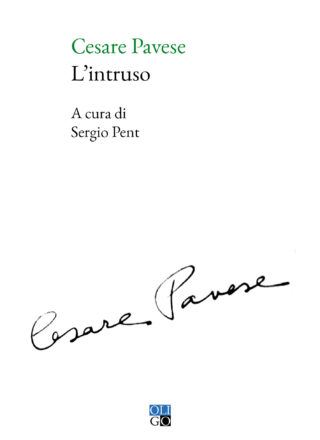 Pubblicato nell’ottobre del 1950, poco dopo la sua morte tragica, sulla storica rivista Rinascita, grazie all’opera meritoria di Oligo editore rivede la luce un racconto dimenticato di Pavese: L’intruso. L’esperienza del confino a Brancaleone Calabro segnò la vita del grande autore piemontese, sia dal punto di vista politico che sentimentale e letterario. Gli ispirò, in particolare, alcune delle più belle poesie di Lavorare stanca, oltre il romanzo breve intitolato Il confino e, appunto, questo racconto, L’Intruso, quasi un atto unico teatrale in cui troviamo una forte concentrazione oltre che il rispetto (forzato, è il caso di dirlo) delle tre unità di tempo, di azione e di luogo. Il breve testo, prefato in maniera affettuosa e poetica da Sergio Pent, presenta l’incontro, fisico e dialettico, tra l’io narrante, un giovane deportato di cui non conosciamo l’imputazione e Lorenzo, cinquantenne abituato alla solitudine, del carcere e non, sospettoso degli intellettuali e dei libri. Un carattere tetragono, quest’ultimo, che dispensa al giovane una serie di consigli pratici, da uomini, che però lui stesso non metterà in pratica nell’impredicibile finale. Il carcere è una trappola quasi metafisica, visto che non c’è alcun riferimento alle circostanze che hanno portato i due in gabbia. A tratti sembra anzi già di star leggendo Morti senza sepoltura o Porta chiusa di Sartre, dove i carcerati si infliggono durissime pene a parole. Se in Sartre si arriverà alla conclusione che “l’Inferno sono gli altri”, qui si parla piuttosto di purgatorio (“Se litighiamo è il Purgatorio”, dice Lorenzo, all’inizio del racconto). I due in effetti sembrano sospesi, in attesa di qualcosa, esauriti ma non ancora sfibrati. In particolare Lorenzo cerca forsennatamente la sua solitudine, intesa come autosufficienza, rifiutando ogni tipo di consolazione, in questo anticipando la celebre scena finale de Lo straniero di Camus, dove Mersault, condannato a morte, rifiuta il prete e le sue preghiere. A livello sentimentale, il breve racconto rivela una visione amara della realtà e una religione della solitudine, probabilmente alimentata dalla vicenda biografica di Pavese stesso che, tornando a Torino, scoprirà che la sua innamorata, la militante comunista a cui aveva nascosto le lettere per cui era stato incriminato, nel frattempo si è sposata con un altro. E, in effetti, in questo racconto esistenzialista il vero carcere è essere dimenticati dagli altri ( “Questa è la pena vera, che il mondo escludesse il recluso”, p.23). Lo stile asciutto, la visione mitica della solitudine, la presenza di frasi sapienziali che richiamano i verghiani motti degli antichi, oltre che il lessico connotato a livello gergale fanno rientrare questo racconto nella grande tradizione della narrativa pavesiana che va da Paesi tuoi a La luna e i falò. Il finale forse po’ frettoloso e comunque lasciato in sospeso non toglie niente alla godibilità della descrizione psicologica accresciuta dal piacere filologico di trovare citazioni da altre opere del grande scrittore di Santo Stefano Belbo. Consigliato a chi ama Pavese.
Pubblicato nell’ottobre del 1950, poco dopo la sua morte tragica, sulla storica rivista Rinascita, grazie all’opera meritoria di Oligo editore rivede la luce un racconto dimenticato di Pavese: L’intruso. L’esperienza del confino a Brancaleone Calabro segnò la vita del grande autore piemontese, sia dal punto di vista politico che sentimentale e letterario. Gli ispirò, in particolare, alcune delle più belle poesie di Lavorare stanca, oltre il romanzo breve intitolato Il confino e, appunto, questo racconto, L’Intruso, quasi un atto unico teatrale in cui troviamo una forte concentrazione oltre che il rispetto (forzato, è il caso di dirlo) delle tre unità di tempo, di azione e di luogo. Il breve testo, prefato in maniera affettuosa e poetica da Sergio Pent, presenta l’incontro, fisico e dialettico, tra l’io narrante, un giovane deportato di cui non conosciamo l’imputazione e Lorenzo, cinquantenne abituato alla solitudine, del carcere e non, sospettoso degli intellettuali e dei libri. Un carattere tetragono, quest’ultimo, che dispensa al giovane una serie di consigli pratici, da uomini, che però lui stesso non metterà in pratica nell’impredicibile finale. Il carcere è una trappola quasi metafisica, visto che non c’è alcun riferimento alle circostanze che hanno portato i due in gabbia. A tratti sembra anzi già di star leggendo Morti senza sepoltura o Porta chiusa di Sartre, dove i carcerati si infliggono durissime pene a parole. Se in Sartre si arriverà alla conclusione che “l’Inferno sono gli altri”, qui si parla piuttosto di purgatorio (“Se litighiamo è il Purgatorio”, dice Lorenzo, all’inizio del racconto). I due in effetti sembrano sospesi, in attesa di qualcosa, esauriti ma non ancora sfibrati. In particolare Lorenzo cerca forsennatamente la sua solitudine, intesa come autosufficienza, rifiutando ogni tipo di consolazione, in questo anticipando la celebre scena finale de Lo straniero di Camus, dove Mersault, condannato a morte, rifiuta il prete e le sue preghiere. A livello sentimentale, il breve racconto rivela una visione amara della realtà e una religione della solitudine, probabilmente alimentata dalla vicenda biografica di Pavese stesso che, tornando a Torino, scoprirà che la sua innamorata, la militante comunista a cui aveva nascosto le lettere per cui era stato incriminato, nel frattempo si è sposata con un altro. E, in effetti, in questo racconto esistenzialista il vero carcere è essere dimenticati dagli altri ( “Questa è la pena vera, che il mondo escludesse il recluso”, p.23). Lo stile asciutto, la visione mitica della solitudine, la presenza di frasi sapienziali che richiamano i verghiani motti degli antichi, oltre che il lessico connotato a livello gergale fanno rientrare questo racconto nella grande tradizione della narrativa pavesiana che va da Paesi tuoi a La luna e i falò. Il finale forse po’ frettoloso e comunque lasciato in sospeso non toglie niente alla godibilità della descrizione psicologica accresciuta dal piacere filologico di trovare citazioni da altre opere del grande scrittore di Santo Stefano Belbo. Consigliato a chi ama Pavese.
SIMONE CONSORTI




